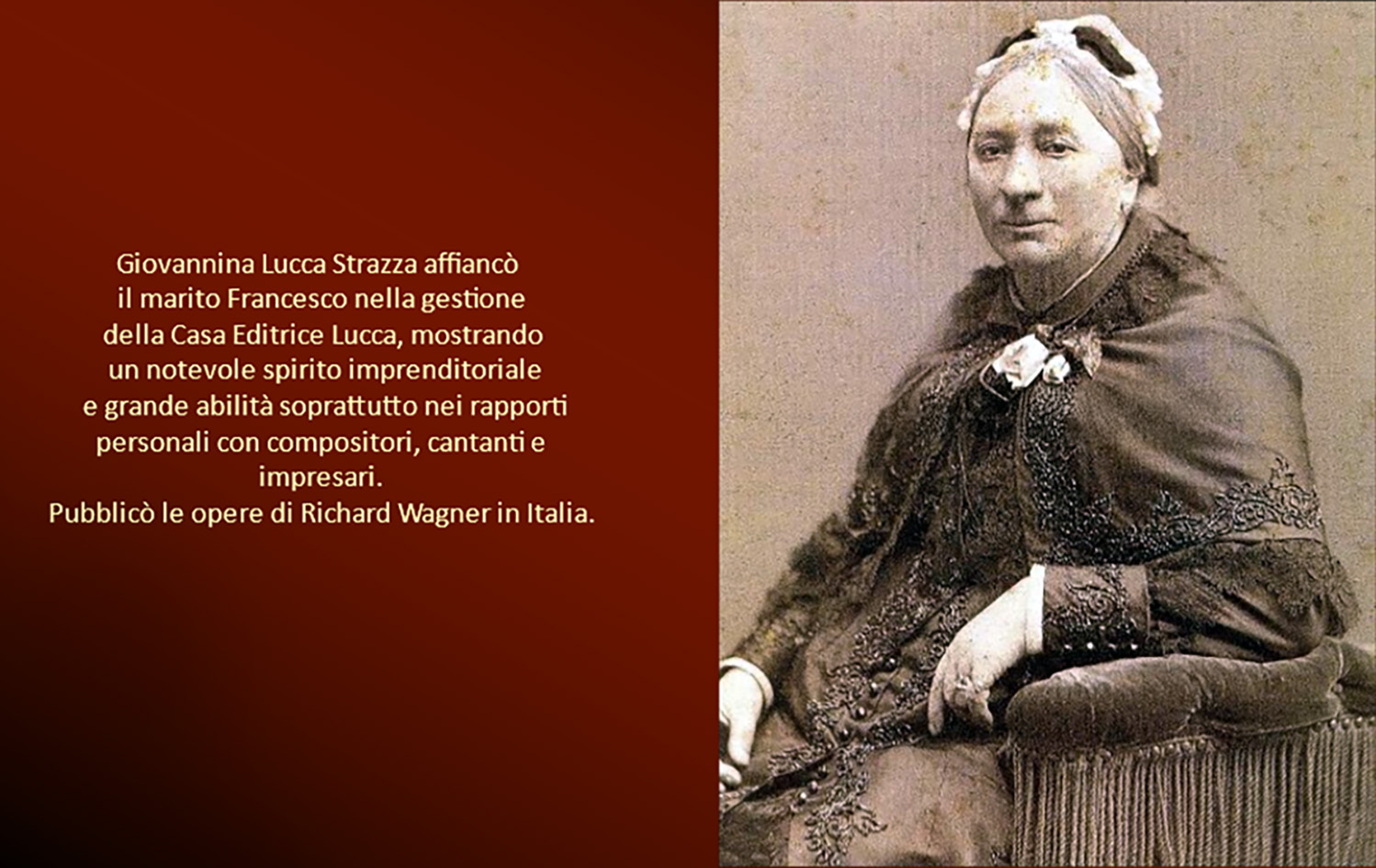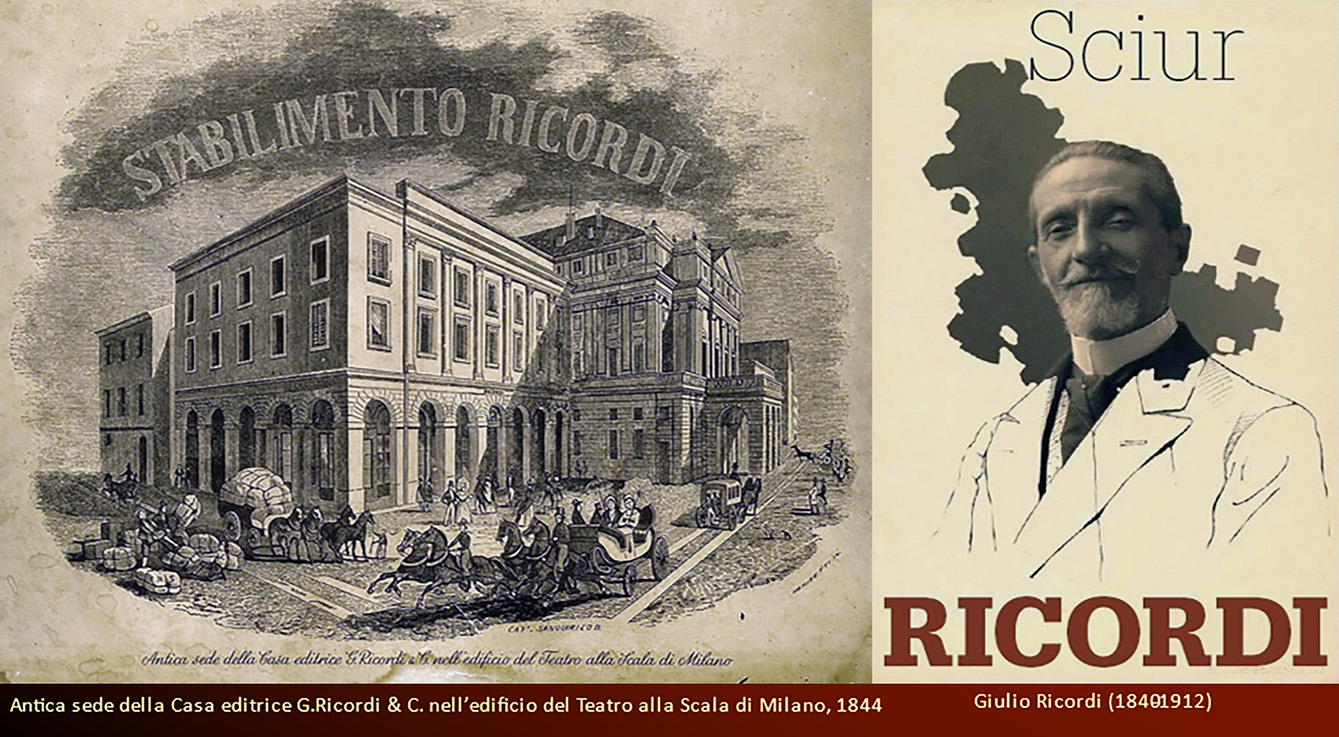
Il fenomeno operistico va osservato anche sotto il punto di vista economico: l’opera lirica permetteva, non solo alle case musicali, ma anche agli impresari dei teatri di realizzare dei cospicui guadagni. Già si è visto come, per la messa in scena di un’opera nuova, di un autore sconosciuto, gli impresari richiedessero una partecipazione alle spese di allestimento, partecipazione che quasi sempre, grazie a messe in scena men che decorose, andava a compensare interamente i costi e pertanto copriva gli impresari da ogni rischio e consentiva, anche nella peggiore delle ipotesi, un minimo di guadagno. È un aspetto dell’arte musicale meno nobile, ma tutt’altro che trascurabile. Gobatti già lo aveva sperimentato. L’aspetto economico non era trascurabile e nemmeno secondario nella fortuna di certe opere, in particolare laddove un allestimento mediocre, cantanti di secondo piano, orchestrali più “economici” concorrevano spesso a fornire prove modeste e poco convincenti. Ed ovviamente le imprese teatrali investivano maggiori risorse sugli autori di fama, sulle opere “sicure”, cioè quelle che comunque riempivano i teatri ed assicuravano lauti guadagni. Ed altrettanto ovviamente, nell’economia di una stagione lirica, le stesse imprese tendevano invece a risparmiare sulle rappresentazioni dalla sorte meno certa, quelle di autori nuovi o misconosciuti o sulle loro opere prime. Per le imprese teatrali, la qualità dell’opera non dipendeva dal valore artistico, bensì dal guadagno che essa poteva fornire: e questo per loro era l’unico criterio di giudizio. I Goti, complessivamente, resero all’impresario un guadagno netto di 38 mila lire, somma favolosa in quei tempi. Gobatti con i suoi ideali e con l’ingenuità di un giovane artista, si trovò calato in questo mondo, fatto anche di tante bassezze, ed oltretutto divenne inconsapevolmente un concorrente pericoloso per i guadagni di tanti altri compositori.